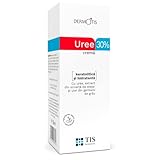La psoriasi ai piedi, conosciuta anche come psoriasi plantare, rappresenta una delle forme più diffuse di questa malattia in quanto colpisce oltre il 60% dei pazienti.
Si tratta di un insieme di manifestazioni leggermente diverse da quelle classiche della patologia psoriasica, che prendono il nome di psoriasi di Barber.
Ultimo aggiornamento 2024-04-07
Indice
In cosa consiste la psoriasi plantare

Solitamente la localizzazione è concentrata a livello della pianta del piede, mentre è quasi sempre assente sul dorso del piede, che può presentare soltanto alcune piccole chiazze isolate di colore rossastro con una scarsa componente squamosa.
Nella pianta del piede invece la pelle modifica del tutto il suo aspetto, diventando ispessita e disidratata, quasi cornea. L’iperproliferazione cutanea consiste nella presenza di squame di grandi dimensioni che arrivano a coprire quasi completamente il calcagno e la zona anteriore della pianta, mentre l’area centrale ne è spesso priva.
La caratteristica distintiva della psoriasi plantare è quella dei “chiodi psoriasici” che consistono in elementi lenticolari circondati da arrossamento simile ad un alone eritematoso.
La psoriasi alla pianta dei piedi è causata da un’intensa replicazione dei cheratociti, con infiltrazione a livello cutaneo dei linfociti TH1. Tali cellule mostrano un’iperproliferazione, con divisione cellulare otto volte maggiore rispetto a quella delle cellule normali. Dallo strato basale dell’epidermide questi elementi sono in grado di raggiungere lo strato superficiale in soli quattro giorni, mentre in assenza di psoriasi, sono richiesti 28 giorni.
I cheratociti neoformati rappresentano una percentuale compresa tra il 60% ed il 100% dello strato germinativo, e contribuiscono a creare le squame disidratate.
Nella psoriasi sotto ai piedi, si verifica inoltre un rallentamento della differenziazione cellulare delle cellule germinali basali causato dall’estrema velocità di replicazione. A tale processo si sovrappone la presenza di flogosi (infiammazione) determinata dall’infiltrazione dei linfociti T a livello epidermico; questa manifestazione fa parte della componente autoimmune della malattia.
Come valutare la gravità della psoriasi plantare
La psoriasi sotto al piede solitamente interessa vaste aree cutanee. La sua gravità è valutata tramite un indice denominato “PASI” (Psoriasis Area Severity Index) che consente al dermatologo di valutare sia l’estensione che la progressione nel tempo delle chiazze psoriasiche, e in alcuni casi l’efficacia dei trattamenti effettuati.
Bisogna ricordare che la psoriasi plantare è una delle forme che mostra maggiori recidive e che risulta più difficile da curare. Probabilmente un fattore predisponente è quello della sollecitazione meccanica, che produce fenomeni di attrito durante la deambulazione.
L’indice del PASI è compreso tra zero (assenza di psoriasi) e 72 (psoriasi in forma grave) e tiene conto non soltanto dell’estensione della superficie interessata ma anche dell’infiltrazione e soprattutto della desquamazione, che è il sintomo più caratteristico della psoriasi ai piedi.
Caratteristiche della psoriasi plantare
Le formazioni psoriasiche di solito si concentrano nella zona del calcagno, sulla superficie dorsale delle dita e negli spazi interdigitali con frequente coinvolgimento intorno all’unghia; le unghie sono colpite per oltre il 60% dei casi e mostrano una ipercheratosi sub-ungueale con frequente distorsione longitudinale.
Una delle caratteristiche principali della psoriasi plantare è quella di presentare anche una componente pustolosa, composta da piccole papule sterili circondate da una zona eritematosa, che producono un intenso bruciore e prurito.
Tali formazioni determinano una notevole compromissione funzionale in quanto l’attività deambulatoria appare estremamente difficoltosa e di solito provoca un peggioramento dei sintomi.
Il disturbo è esacerbato dalla presenza di lesioni cutanee e traumi pregressi che contribuiscono a creare un substrato favorevole all’insorgenza delle tipiche manifestazioni; anche l’utilizzo di detergenti inadeguati con pH troppo acido o troppo alcalino si comporta da fattore scatenante.
Trattandosi di una forma piuttosto subdola, la psoriasi plantare viene spesso confusa con altre patologie dermatologiche e pertanto si consiglia la biopsia per una corretta diagnosi che escluda altre forme eczematose della cute.
Un’altra caratteristica della psoriasi ai piedi è l’infiammazione localizzata a livello della barriera dermo-epidermica, conseguente all’interazione di numerosi tipi di cellule come i dendrociti, i fibroblasti, i linfociti TH1 e le cellule polimorfonucleate che proliferano contemporaneamente ai cheratinociti.
Ultimo aggiornamento 2024-04-07
Tale proliferazione avviene con due modalità: per contatto diretto intercellulare o tramite l’azione delle citochine. In quest’ultimo caso vengono coinvolti mediatori specifici che rinforzano i segnali biochimici delle cellule.
Dal punto di vista genetico la psoriasi ai piedi è stata collegata ad un potenziamento dell’espressione di alcune componenti proto-oncogene o anche ad una mutazione cromosomica del gene P53. A tali manifestazioni sembra che si aggiungano alterazioni quantitative o qualitative che interessano i cheratociti, alcune cellule endoteliali polimorfonucleate e i fibroblasti.
I cheratinociti interessati alla psoriasi plantare presentano tipiche modificazioni che comprendono la presenza di vescicole lungo la porzione basale di alcune cellule germinative. Inoltre si osserva una maggiore presenza di cheratina iperproliferativa con aumento della componente proteica (psoriasina e calgranulina).
Subentrano anche delle anomalie funzionali a livello dei recettori di membrana dei cheratinociti psoriasici, tale situazione potrebbe indicare un coinvolgimento delle strutture nervose nella genesi della malattia.
Cause della psoriasi plantare
Anche per la psoriasi plantare, l’eziologia è collegabile a tre ipotesi: immunologica, neurologica ed endocrina.
L’ipotesi immunologica prende in considerazione l’attivazione dei linfociti T indotta da varie cause, come infezioni batteriche o virali, soprattutto a carico di streptococco, oppure da stimoli chimici o fisici, da tossine o da neuropeptidi cutanei, che rilasciano citochine attivanti sui linfociti.
L’ipotesi neurologica si ricollega all’influenza di fattori emotivi,alla assunzione di farmaci, a traumi o infezioni, che provocherebbero la secrezione di neuropeptidi tra cui la sostanza P.
L’ipotesi endocrina prende in considerazione la possibilità che alla base della flogosi possano esserci delle sostanze ormonali, tra cui la beta endorfina.
Bisogna infine considerare che i traumi rappresentano un fattore sia predisponente che scatenante della malattia, così come le infezioni; l’esposizione solare può migliorare il decorso della patologia, mentre lo stress ed alcuni farmaci lo peggiorano.
Quali sono i sintomi della psoriasi plantare
I sintomi della psoriasi ai piedi comprendono la presenza di ampie zone di papule squamose di solito arrotondate e con margini netti, a volte circondate da un alone biancastro (alone di Voronoff).
Le squame, biancastre oppure argentee, sono caratterizzate da grandi dimensioni e notevole spessore, ed in molti casi possono assomigliare a valve di una conchiglia.
Se vengono grattate, tali squame si staccano con facilità lasciando scoperta un’area traslucida costituita da una pellicola quasi trasparente che, se rimossa, provoca sanguinamento.
Quali sono le terapie per la psoriasi plantare
Come primo attacco, le cure per la psoriasi ai piedi utilizzano preparati topici, come creme, unguenti, lozioni oppure gel da applicare localmente sulle zone interessate. Ecco la classifica delle migliori sul mercato:
Ultimo aggiornamento 2024-04-14
Viene consigliato anche di effettuare quotidianamente bagni in acqua tiepida ed amuchina per ammorbidire le formazioni squamose che successivamente tendono a staccarsi spontaneamente.
Possono essere utili alcuni rimedi naturali, come creme a base di vaselina e oli vegetali spesso associati ad acido salicilico, la cui funzione è il decapaggio necessario prima di ogni intervento farmacologico.
Vengono spesso prescritti prodotti topici a base di catrame minerale o vegetale (come l’olio di ginepro). Altri rimedi naturali prevedono l’utilizzo di ditranolo, una sostanza estratta dalla corteccia di alcune piante.